L’attesa spasmodica per l’avvio della conquista dell’Iraq da parte dell’esercito statunitense sembra aver contagiato ormai in maniera definitiva l’opinione pubblica internazionale. Seppure molte sono ancora le voci che si levano contro l’intervento militare, nessuno sembra credere davvero che lo schieramento di forze messo in campo dagli USA possa rimanere ancora a lungo inattivo. Del resto gli intenti del presidente Bush e dei suoi sono chiari e nemmeno celati: l’Iraq verrà affidato per diciotto mesi al governo del generale Tommy Franks (eventualmente affiancato da un civile di nomina ONU), il paese verrà ricostruito (dopo i bombardamenti ce ne sarà bisogno) e con esso le infrastrutture politiche, economiche e sociali, sfruttando le risorse petrolifere per il reperimento dei necessari fondi (che presumibilmente finiranno nelle tasche delle imprese – americane? – che se ne occuperanno). La motivazione è nobile e umanitaria: il popolo iracheno merita di essere liberato dalle angherie del raìs di Bagdad e il resto del mondo merita di essere liberato dalla minaccia del terrorismo internazionale. Sulla sincerità di detti intenti sono in molti a nutrire dubbi e perplessità. Altrettanti ne hanno scritto, con dovizia di particolari, e ripetere quanto già è noto è utile, come insegna l’antica saggezza, ma al tempo stesso mette in dubbio l’intelligenza di chi ascolta. Limitiamoci perciò a riportare alcuni fatti più o meno incontestabili. Il signor Saddam Hussein non è al suo posto per caso. Purtroppo, data l’oggettiva impossibilità di reperire altrettanto oggettive informazioni sugli orientamenti dell’opinione pubblica irachena (se qualcuno ha fonti al di sopra d’ogni sospetto alzi la mano), non è dato sapere se egli goda o meno dell’appoggio popolare di cui si fa vanto. Ne dubitiamo, ma – tant’è – resta un punto di vista. Sappiamo invece, con maggiore certezza, come il nostro uomo sia giunto a mettere (e mantenere) il sedere sulla poltrona che occupa: i primi contatti con i servizi segreti americani risalgono ai primi anni sessanta, quando il giovane Saddam, militante di spicco dell’allora movimento terroristico Baath, si trovava in Egitto, e il ruolo giocato dalla CIA in appoggio dei colpi di stato baasisti del ’63 e poi ancora del ‘68 che portarono il raìs al potere in funzione antisovietica sono ben documentati. La storia vuole ancora che sul finire degli anni ottanta la Casa Bianca avesse bisogno di qualcuno che desse del filo da torcere agli antipatici iraniani e che il prescelto, l’eletto, fosse una volta di più lui, Saddam. Sappiamo dunque come il raìs abbia goduto del favore politico ed economico del mondo occidentale per lungo tempo, come sia stato a lungo sovvenzionato, sponsorizzato e opportunamente rifornito degli armamenti necessari. Possiamo addirittura presumere che le armi che egli nega di avere siano in buona parte le stesse che noi gli abbiamo venduto e che, pertanto, egli mente. E a noi i bugiardi non piacciono. Ma ai bugiardi, come alle spie, al massimo si taglia la lingua. Per seppellirli di bombe, anche se intelligenti, serve dell’altro. Procediamo dunque nell’analisi e parliamo del terrorismo. Dopo l’11 settembre 2001 abbiamo assistito a una discreta sequenza di attentati e azioni terroristiche. Fatta eccezione per quanto avvenuto al teatro Dubrovka di Mosca, i paesi colpiti sono tutti mussulmani. Sebbene i morti sul campo, gli obbiettivi diretti, per così dire, fossero americani, francesi, tedeschi, israeliani, eccetera, le conseguenze reali di quelle azioni le pagano oggi quegli stessi paesi che le hanno subite: paesi come il Kenya e Bali hanno visto dimezzarsi l’afflusso di turisti e così venir meno la propria principale fonte di sostentamento. Dovrebbero anche loro aver paura dei terroristi e dell’Iraq, ammesso per ipotesi – e non concesso in quanto da dimostrare – che un legame esista tra Iraq e terrorismo. Ma loro non sanno o non possono (o non vogliono?) difendersi, sicché li aiutiamo noi nella guerra al comune nemico. Il legame tra Iraq e terrorismo, però – come detto – è tutto da dimostrare, e voci recenti parlano di dubbi sorti fra le fila stesse di CIA e FBI: “gli 007, - scrive Guido Olimpio dalle pagine del Corriere della Sera – non escludono l’esistenza di un’assistenza dell’Iraq ad Al Qaeda, tuttavia affermano che le prove non sono così solide come si è lasciato credere.”. Quel che gli ispettori ONU stanno a fare in Iraq è dunque un lavoro inutile. A che serve dimostrare che Saddam stia o meno armandosi? E quanti paesi al mondo stanno facendo lo stesso? E quanti ancora sono ben più avanti sulla medesima strada? E’ dunque sufficiente che l’Iraq si armi per dedurne le cattive intenzioni e i legami con Al Qaeda? Se così fosse, a noi la prima bomba! Ma così non è, ché i processi si fanno sui fatti, e le sentenze si emettono a fine processo, in primis, e, soprattutto, si circostanziano con prove solide e inconfutabili. A maggior ragione se sono sentenze di morte. Non bastano gli spizzichi e i bocconi di un Colin Powell in cerca di alleati. Così è, invece, nei fatti: il mondo intero aspetta che l’ONU sancisca quel che potrebbe essere del tutto vero: l’Iraq è armato. Nessuno si chiede se questo sia sufficiente a muovergli una guerra. Il sentimento generale pare come di rassegnazione. Sappiamo che succederà, dunque prepariamoci. Ma perché si farà? Di fatto la risposta la sanno tutti, ma nessuno ne parla apertamente, forse perché ha il colore dell’oro che non risplende: il petrolio. Gli Stati Uniti sono stati per lungo tempo i principali produttori mondiali di greggio, e se fino agli anni cinquanta detenevano oltre la metà del mercato mondiale, solo vent’anni dopo toccavano il picco della produzione: dal 1970 in poi gli USA hanno visto velocemente ridursi la propria autonomia (e supremazia) energetica , rimanendo tuttavia – a tutt’oggi – la nazione dai consumi più elevati: nel 2002 sono stati in grado di coprire solo l’11% del proprio fabbisogno con risorse interne, riducendo così le proprie riserve petrolifere a un magro 2% delle riserve mondiali totali. La popolazione americana costituisce il 5% di quella mondiale, ma assorbe correntemente oltre un quarto del petrolio estratto nel mondo. Ciononostante, le importazioni USA dai paesi OPEC sono oggi inferiori, in termini percentuali, a quelle di venticinque anni or sono. Secondo il documentatissimo Rifkin, che si avvale degli studi di Campbell e Laherrère e di molti altri, “la produzione globale di petrolio raggiungerà il picco fra il 2010 e il 2020 (secondo alcuni, addirittura prima del 2010). […] I produttori non-OPEC raggiungeranno il picco prima del 2010, mentre i cinque principali paesi OPEC del Medio Oriente – Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Iran e Abu Dhabi – lo raggiungeranno probabilmente nel 2015.”. Questo equivale a dire – e non c’è bisogno della sfera di cristallo per azzardare simili previsioni – che al più tardi tra una quindicina d’anni – sic stantibus rebus – assisteremo a una progressiva impennata del costo del greggio, a tutto vantaggio delle sole nazioni del Medio Oriente, che saranno in quel momento le uniche e sole sul pianeta a poterne ancora estrarre in quantità significativa. Alla luce di simili profezie, sottoscritte peraltro in più occasioni dall’autorevole International Energy Agency dell’OCSE, l’importanza vitale di un posto al sole tra il Tigri e l’Eufrate appare evidente. Si badi bene: non facciamo le pulci ai nemici, e nemmeno agli amici. Quel posto al sole non è un’ambizione tutta a stelle e strisce: in quanto alleati della superpotenza, tutti i paesi che orbitano nella NATO (e qualcuno che vi gira intorno), potrebbero trarre benefici se i pozzi iracheni si dipingessero di bianco, rosso e blu. Tutti, tranne qualcuno. Parigi e Mosca, forse con lungimiranza, forse sottovalutando la determinazione della Casa Bianca, sembrano aver ripreso ultimamente i contatti con Bagdad. Non è un caso se dalla probabile guerra all’Iraq hanno preso le distanze, e non certo (o non solo, ci piacerebbe dire) per motivi etici e politici. Tanto più che la grande Russia di Vladimir Vladimirovič Putin si ritrova a dover difendere la posizione appena conquistata di primo produttore mondiale di greggio. Ma facciamo ancora un passo e andiamo a visitare dall’altra parte del mondo il tenente colonnello Hugo Rafael Chávez Frías. Stando alle stime degli analisti della Wood Mackenzie, da quando nel paese imperversano gli scioperi le maggiori compagnie petrolifere che operano in Venezuela perdono complessivamente 6,7 milioni di dollari al giorno. La sola Eni, quarta tra le compagnie europee per volumi di mercato,
perde 870.000 dollari al giorno da quando, il 17 dicembre dello scorso anno, è stato chiuso il suo giacimento Dacion. Il calo di produzione, valutato attorno ai 980.000 barili di greggio al giorno, incide parimenti sui conti di Total Fina Elf SA, Conoco Phillips, Exxon Mobil Corporation, Chevron Texaco Corporation., Royal Dutch/Shell Group, Statoil ASA, Repsol YPF SA, BP Plc e Petro-Canada. Di più: stando agli esperti del settore, il Venezuela vedrà fortemente ridursi la sua quota sul mercato mondiale del greggio per almeno sei mesi dopo la fine degli scioperi, e potrebbe impiegare anni per tornare ai suoi livelli abituali. Se consideriamo che nella lista dei fornitori di oro nero agli USA il Venezuela occupa un posto di prim’ordine, non desta meraviglia che Washington si sia affrettata a riconoscere a tempo di record il governo del presidente della confindustria venezuelana, Pedro Carmona Estanga, all’indomani del colpo di stato che nello scorso aprile aveva costretto Chàvez alle dimissioni. Non desta meraviglia che abbia subito provveduto a manifestare soddisfazione per “la democrazia ritrovata” di un paese dal quale importa 1 milione e 200 mila barili di petrolio al giorno. Non desta meraviglia il disappunto per il ritorno al potere di Chàvez dopo soli due giorni. Le conseguenze di questo clima caldo sono ovvie, visto che l’oro nero è soggetto a evaporazione: il prezzo del greggio ha marcato il record sfondando la soglia dei 30 dollari al barile, segnando un aumento di poco inferiore al 20% rispetto alla media del 2002.
Ancora dubbi? Perché parlare di scopi umanitari e nobili quando ve n’è uno sopra gli altri che non ha pari? Sopravvivenza, produzione, consumi, benessere. Tutto grazie al petrolio. La nostra macchina non può far senza, e dove non arriva il portafogli possono arrivare gli aeroplani. Ora, il punto è un altro. Si tratta in primo luogo di decidere se continuare ad anteporre il nostro benessere a quello del resto del mondo, e, quando avessimo deciso di perseverare in questa folle quanto poco umana e per nulla eroica tentazione, se affidare agli Stati Uniti lo stendardo del nostro futuro. A voi la scelta, ai posteri (quelli che rimarranno) l’ardua sentenza.
Note:
1. I piani della Casa Bianca sono stati anticipati dal New York Times del 6 gennaio 2003. Si veda anche, fra gli altri, l’articolo di Ennio Caretto titolato “La Casa Bianca pronta a governare l’Iraq” pubblicato su Il Corriere della Sera del 7 gennaio 2003, pagina 2.
2. Si veda in proposito, tra gli altri, Magdi Allam, “Saddam, storia segreta di un dittatore.”, Milano, Mondadori, 2003
3. Il 17 marzo 2002, in Pakistan, una bomba viene lanciata contro una chiesa protestante di Islamabad. Il bilancio è di cinque morti, due dei quali americani. L’11 aprile, in Tunisia, un’ autocisterna guidata da un kamikaze esplode vicino alla sinagoga di Djerba provocando 20 morti, tra cui 14 turisti tedeschi. Ancora in Pakistan, l’8 maggio un kamikaze alla guida di un'auto imbottita di tritolo colpisce un autobus uccidendo 14 tecnici francesi e 3 passanti e il 14 giugno un'autobomba esplode davanti al consolato USA a Karachi. Nell'esplosione restano uccise 12 persone. Il 6 ottobre, nello Yemen un'esplosione apre il fianco della petroliera francese “Limburg”. Muore un marinaio. L’8 ottobre, nell'isola di Faikala, Kuwait, due uomini armati sparano contro soldati statunitensi impegnati in manovre militari e colpiscono a morte un marine. I militari a loro volta uccidono i due aggressori. Il 10 ottobre una bomba viene lanciata contro la fermata di un autobus a Kidapawan, nelle Filippine. I morti sono 6. Il 12 ottobre tre esplosioni seminano distruzione a Kuta Beach, nell'isola di Bali. Nell'attentato muoiono 190 persone, tra cui numerosi turisti. Il 17 ottobre, ancora nelle filippine, due bombe provocano 7 morti in una zona commerciale di Zamboanga. Il 26 ottobre un commando di guerriglieri ceceni, tra cui 18 donne, assalta il teatro Dubrovka di Mosca, prendendo in ostaggio circa 800 persone. I guerriglieri minacciano di far saltare il teatro ma due giorni dopo un blitz delle forze speciali russe li uccide tutti, lasciando sul campo anche 129 ostaggi, morti avvelenati dai gas usati dalle forze speciali. Da ultimo, il 28 novembre una jeep carica di esplosivo si scaglia contro un hotel a Mombasa, Kenya, pieno di turisti israeliani. 15 persone muoiono. Poco prima due razzi vengono sparati contro un aereo della compagnia israeliana Arkia durante il decollo, mancando il bersaglio. Il tutto mentre in Israele a Beith Shein un kamikaze fà strage in una sede del Likud.
4. Guido Olimpio, “CIA e FBI ora hanno paura che il castello di prove cada”, Milano, Corriere della Sera del 3 febbraio 2003, p.8.
5. Walter Youngquist, “GeoDestinies. The inevitable control of Earth resources over nations and individuals.”, Portland, National Book Company, 1997.
6. EIA, “World crude oil and natural gas reserves. January 1, 2000”, (http://www.eia.doe.gov/emeu/iea/table81.html), aggiornamento del 5 febbraio 2001; EIA, “World oil demand. 1990-present”, (http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t14.txt); EIA, “World oil demand. 1997-2001”, (http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t24.txt).
7. Jeremy Rifkin, “Economia all’idrogeno”, Milano, Mondadori, 2002.
8. Di possibili accordi tra Parigi e Mosca e Bagdad per lo sfruttamento dei pozzi iracheni parla, tra gli altri, Arthur Schlesingher, storico ed ex consigliere di Kennedy, in un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera del 5 febbraio 2003.
9. Sabrina Tavernise, “Russian to keep limits on oil exports trough June”, su The New York Times del 21 marzo 2002, cit. in Rifkin, op. cit.
10. Thomas Tugendhat, “Venezuela: le petrolifere perdono $6,7 mln/giorno”, Bloomberg, 23 gennaio 2003.
11. Mark Shenk, “Venezuela oil output recovery to lag strike's end”, Bloomberg, 27 gennaio 2003.
12. “Opec: prezzo record del petrolio degli ultimi 2 anni.”, comunicato ANSA del 21 gennaio 2003.
perde 870.000 dollari al giorno da quando, il 17 dicembre dello scorso anno, è stato chiuso il suo giacimento Dacion. Il calo di produzione, valutato attorno ai 980.000 barili di greggio al giorno, incide parimenti sui conti di Total Fina Elf SA, Conoco Phillips, Exxon Mobil Corporation, Chevron Texaco Corporation., Royal Dutch/Shell Group, Statoil ASA, Repsol YPF SA, BP Plc e Petro-Canada. Di più: stando agli esperti del settore, il Venezuela vedrà fortemente ridursi la sua quota sul mercato mondiale del greggio per almeno sei mesi dopo la fine degli scioperi, e potrebbe impiegare anni per tornare ai suoi livelli abituali. Se consideriamo che nella lista dei fornitori di oro nero agli USA il Venezuela occupa un posto di prim’ordine, non desta meraviglia che Washington si sia affrettata a riconoscere a tempo di record il governo del presidente della confindustria venezuelana, Pedro Carmona Estanga, all’indomani del colpo di stato che nello scorso aprile aveva costretto Chàvez alle dimissioni. Non desta meraviglia che abbia subito provveduto a manifestare soddisfazione per “la democrazia ritrovata” di un paese dal quale importa 1 milione e 200 mila barili di petrolio al giorno. Non desta meraviglia il disappunto per il ritorno al potere di Chàvez dopo soli due giorni. Le conseguenze di questo clima caldo sono ovvie, visto che l’oro nero è soggetto a evaporazione: il prezzo del greggio ha marcato il record sfondando la soglia dei 30 dollari al barile, segnando un aumento di poco inferiore al 20% rispetto alla media del 2002.
Ancora dubbi? Perché parlare di scopi umanitari e nobili quando ve n’è uno sopra gli altri che non ha pari? Sopravvivenza, produzione, consumi, benessere. Tutto grazie al petrolio. La nostra macchina non può far senza, e dove non arriva il portafogli possono arrivare gli aeroplani. Ora, il punto è un altro. Si tratta in primo luogo di decidere se continuare ad anteporre il nostro benessere a quello del resto del mondo, e, quando avessimo deciso di perseverare in questa folle quanto poco umana e per nulla eroica tentazione, se affidare agli Stati Uniti lo stendardo del nostro futuro. A voi la scelta, ai posteri (quelli che rimarranno) l’ardua sentenza.
Note:
1. I piani della Casa Bianca sono stati anticipati dal New York Times del 6 gennaio 2003. Si veda anche, fra gli altri, l’articolo di Ennio Caretto titolato “La Casa Bianca pronta a governare l’Iraq” pubblicato su Il Corriere della Sera del 7 gennaio 2003, pagina 2.
2. Si veda in proposito, tra gli altri, Magdi Allam, “Saddam, storia segreta di un dittatore.”, Milano, Mondadori, 2003
3. Il 17 marzo 2002, in Pakistan, una bomba viene lanciata contro una chiesa protestante di Islamabad. Il bilancio è di cinque morti, due dei quali americani. L’11 aprile, in Tunisia, un’ autocisterna guidata da un kamikaze esplode vicino alla sinagoga di Djerba provocando 20 morti, tra cui 14 turisti tedeschi. Ancora in Pakistan, l’8 maggio un kamikaze alla guida di un'auto imbottita di tritolo colpisce un autobus uccidendo 14 tecnici francesi e 3 passanti e il 14 giugno un'autobomba esplode davanti al consolato USA a Karachi. Nell'esplosione restano uccise 12 persone. Il 6 ottobre, nello Yemen un'esplosione apre il fianco della petroliera francese “Limburg”. Muore un marinaio. L’8 ottobre, nell'isola di Faikala, Kuwait, due uomini armati sparano contro soldati statunitensi impegnati in manovre militari e colpiscono a morte un marine. I militari a loro volta uccidono i due aggressori. Il 10 ottobre una bomba viene lanciata contro la fermata di un autobus a Kidapawan, nelle Filippine. I morti sono 6. Il 12 ottobre tre esplosioni seminano distruzione a Kuta Beach, nell'isola di Bali. Nell'attentato muoiono 190 persone, tra cui numerosi turisti. Il 17 ottobre, ancora nelle filippine, due bombe provocano 7 morti in una zona commerciale di Zamboanga. Il 26 ottobre un commando di guerriglieri ceceni, tra cui 18 donne, assalta il teatro Dubrovka di Mosca, prendendo in ostaggio circa 800 persone. I guerriglieri minacciano di far saltare il teatro ma due giorni dopo un blitz delle forze speciali russe li uccide tutti, lasciando sul campo anche 129 ostaggi, morti avvelenati dai gas usati dalle forze speciali. Da ultimo, il 28 novembre una jeep carica di esplosivo si scaglia contro un hotel a Mombasa, Kenya, pieno di turisti israeliani. 15 persone muoiono. Poco prima due razzi vengono sparati contro un aereo della compagnia israeliana Arkia durante il decollo, mancando il bersaglio. Il tutto mentre in Israele a Beith Shein un kamikaze fà strage in una sede del Likud.
4. Guido Olimpio, “CIA e FBI ora hanno paura che il castello di prove cada”, Milano, Corriere della Sera del 3 febbraio 2003, p.8.
5. Walter Youngquist, “GeoDestinies. The inevitable control of Earth resources over nations and individuals.”, Portland, National Book Company, 1997.
6. EIA, “World crude oil and natural gas reserves. January 1, 2000”, (http://www.eia.doe.gov/emeu/iea/table81.html), aggiornamento del 5 febbraio 2001; EIA, “World oil demand. 1990-present”, (http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t14.txt); EIA, “World oil demand. 1997-2001”, (http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t24.txt).
7. Jeremy Rifkin, “Economia all’idrogeno”, Milano, Mondadori, 2002.
8. Di possibili accordi tra Parigi e Mosca e Bagdad per lo sfruttamento dei pozzi iracheni parla, tra gli altri, Arthur Schlesingher, storico ed ex consigliere di Kennedy, in un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera del 5 febbraio 2003.
9. Sabrina Tavernise, “Russian to keep limits on oil exports trough June”, su The New York Times del 21 marzo 2002, cit. in Rifkin, op. cit.
10. Thomas Tugendhat, “Venezuela: le petrolifere perdono $6,7 mln/giorno”, Bloomberg, 23 gennaio 2003.
11. Mark Shenk, “Venezuela oil output recovery to lag strike's end”, Bloomberg, 27 gennaio 2003.
12. “Opec: prezzo record del petrolio degli ultimi 2 anni.”, comunicato ANSA del 21 gennaio 2003.
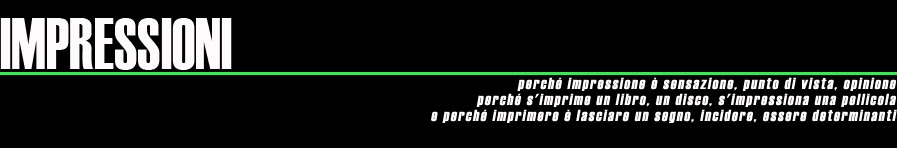.jpg)
Nessun commento:
Posta un commento