
Quaranta anni orsono, la mattina del 25 novembre 1970, Hiraoka Kimitake, noto al mondo con lo pseudonimo di Yukio Mishima, si reca presso la sede del suo editore dove è atteso per la consegna della stesura definitiva del suo ultimo romanzo.
Tennin gosui, “La caduta degli angeli”, è il titolo dell’opera che chiude la tetralogia de “Il mare della fertilità”.
Immediatamente dopo, accompagnato dai più fedeli compagni della Tate no Kai, la Società degli Scudi, da lui stesso fondata cinque anni prima, si reca a Ichigawa, presso il Quartier Generale del Jieitai, la forza di autodifesa dell’esercito giapponese. Gli uomini della Tate no Kai hanno partecipato a più di una esercitazione militare del Jieitai, distinguendosi altrettante volte per ardimento. Le loro divise sono ben conosciute e la loro guida non ha bisogno di presentazioni. Mishima porta con sé una preziosa sciabola. E’ questo il motivo della visita: mostrare il cimelio al Generale Kanetoshi Mashita. Ottenuto il permesso per essere ricevuti dal Comandante il gruppo agisce secondo un copione già scritto e studiato nei minimi particolari. Mashita viene preso in ostaggio dopo una breve quanto violenta colluttazione. Diversi uomini della sua guardia vengono feriti. Il colpo di mano riesce. Mishima chiede e ottiene che tutto il personale militare presente venga riunito nella piazza d’armi. Giungono nel frattempo anche i giornalisti di radio, stampa e televisione. Alcuni elicotteri sorvolano la caserma. Mishima, affacciato al balcone dell’ufficio di Mashita, pronuncia il suo discorso di condanna del decadimento morale, sociale e culturale del Giappone del dopoguerra e, dopo aver reso pubblicamente gli onori all’Imperatore, rientra nella stanza. Con estrema freddezza sfodera la sciabola, si sfila la giacca della divisa della Società degli Scudi, si inginocchia assumendo la corretta posizione e, senza muovere un solo muscolo del viso, si apre il ventre nell’atto del seppuku. Il codice del suicidio rituale vuole che, per evitare che il maestro emetta il benché minimo lamento che tradisca il suo dolore prima della morte, il più giovane degli allievi gli tagli il capo con un colpo secco di sciabola. Il compito spetta al giovanissimo Masakatsu Morita, il quale in preda all’emozione e al pianto fallisce per due volte l’operazione limitandosi a ferire profondamente a una spalla il maestro. Solo l’intervento risolutivo di un compagno più anziano ed esperto pone fine all’agghiacciante scena. Morita segue la sorte di Mishima immediatamente dopo. La giovane età gli risparmia i dolori del seppuku: la sua testa cade prima che la lama penetri a fondo nel ventre.
Mishima non era un uomo qualunque. Aveva trentacinque anni, nel ’70, centinaia di libri e racconti all’attivo pubblicati in tutte le lingue in tutto il mondo, almeno una decina di cariche di prim’ordine in alcune delle principali istituzioni culturali giapponesi e un passato di attore e regista di teatro e cinema. I suoi drammi venivano regolarmente rappresentati al teatro Kabuki di Tokio, la sua collaborazione richiesta dalle migliori Università di tutto il mondo. Nel ’69 la rivista americana Esquire includeva l’”Hemingway giapponese” fra i cento uomini più importanti della Terra. Per capire quanto intensa e profonda sia stata la sua esistenza consiglio di leggere quanto ha scritto Marguerite Yourcenar nel libro a lui dedicato.
L’epilogo violento di una delle vite più brillanti del nostro secolo impone una riflessione assai “fastidiosa”: l’atto, l’azione fine a sé stessa, in questa nostra moderna società del continuo movimento è in realtà un fatto sempre più raro. Non è un paradosso. Il nostro mondo in corsa è incredibilmente immobile. E’ un mondo in cui il gesto è meccanico, l’abitudine prevale sul rito e ogni “azione” è tale solo in quanto “finalizzata” a un che di concreto, ossia è in sé sostanzialmente “vuota”. Lascio ad altri ogni esemplificazione e mi limito a girare una domanda: “Esiste qualcosa in questa nostra fragile vita, che più di un fuoco d’artificio possegga l’eternità dell’istante?” Mishima ritiene di rispondere al quesito ch’egli stesso pone con la morte, atto estremo e al tempo stesso supremo: “Ho scoperto che la Via del Samurai è la morte. Un dilemma di vita o di morte va risolto, semplicemente, scegliendo una sùbita morte.” Questo l’insegnamento dell’Hagakure. Il suicidio non appartiene alla nostra cultura, sicché è quanto mai logico aspettarsi che non lo si comprenda, che lo si scambi per una scioccheria, un’insensatezza e null’altro. Alla nostra tradizione appartiene invece il rito, atto significante per diritto di nascita, ma anche ad esso non siamo più in grado di tributare alcun senso. E’ forse questo il segno più profondo del Kaliyuga , dell’epoca di decadimento che andiamo attraversando? L’incapacità di attribuire un significato intrinseco a quel che ogni giorno facciamo? L’impossibilità di curarci dei nostri gesti in un mondo in cui il primo obiettivo da perseguire è la velocità d’azione piuttosto che lo stile? “La vita umana non dura che un istante. Si dovrebbe trascorrerla a far quello che piace. A questo mondo, fugace come un sogno, vivere nell’affanno, facendo solo ciò che spiace, è follia.” Di nuovo un pensiero “fastidioso”. Di nuovo un sasso pesante. Di nuovo l’Hagakure. La morte è la via, la via è la vita, la vita esige l’azione e ogni azione degna di tal nome esige un senso, un piacere. L’azione è per Mishima il segno della ribellione all’immobilismo dilagante nel suo Giappone di fronte all’invasione del pensiero occidentale, di fronte alla dissipazione della millenaria tradizione del suo popolo. L’immobilismo stesso, inteso come susseguirsi di azioni prive di significato, incapaci di alcun “disegno”, è quel che violenta la tradizione. “Penso che l’essenza di un’azione pura consista nel raggiungere lo scopo dopo aver sfiorato l’abisso dello scacco” egli scrive ancora in “Lezioni spirituali per giovani samurai”. Yukio Mishima risponde alle facili leggi del capitalismo occidentale, laddove ciò che “appare” viene scambiato per ciò che “è”, con l’esempio del suo gesto estremo, quel suicidio rituale che è luogo frequentatissimo della tradizione di cui egli si nutre e nella quale irrimediabilmente tutto ciò che appare “significa”. Il rito dunque, di fronte all’immagine. Apparenze entrambe, ma l’una pregnante, l’altra vacua. L’una incastonata in quel susseguirsi di eventi che è la storia, l’altra incapace di alcun effetto permanente e condannata all'effimero in eterno. L’una gravida di conseguenze, l’altra semplicemente impotente, incapace di lasciare alcun segno di sé. L’una cruda e reale, incredibilmente reale come la morte di un uomo vivo in ogni istante della sua esistenza, l’altra eterea, sfuggente, giammai appagante. E questo forse ci da il segno di come Mishima sia stato realmente poeta, non solo in quanto scrittore, ma in quanto uomo d’azione. Poesia, in effetti – non dimentichiamolo – è parola che allude non a caso all’azione, apogeo creativo dell’umano, avendo la sua radice nel verbo che per i greci antichi significava fare. In un’epoca senza poesia come la nostra dovremmo seriamente meditare di fermarci di quando in quando ad agire.
Secondo la tradizione indiana il tempo è scandito da ere ciascuna delle quali dominata dallo spirito di una divinità. L’era attuale è dominata alla dea Kalì - da cui Kaliyuga - dea malvagia e prepotente, ed è un’era di profondo decadimento.
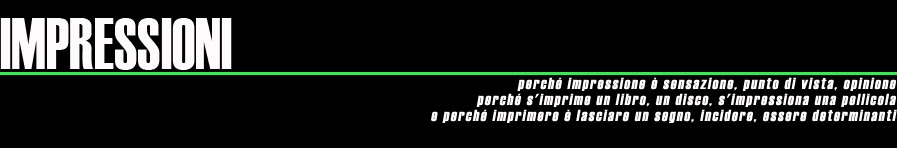.jpg)
Nessun commento:
Posta un commento