Il paradosso federalista
Calogero Muscarà
Marsilio Editori, 2001
Cominciamo dalla fine: il paradosso federalista è il prodotto di due esigenze in sé contrapposte che dovranno però in qualche modo giungere a una conciliazione. Trattasi di una universale quanto evidente domanda di globalizzazione e di una un po’ più italiana ma altrettanto innegabile domanda di federalismo. Frutto di tale ineluttabile connubio sarà un paradosso che vedrà la devoluzione alle attuali istituzioni locali di una quantità di prerogative oggi di competenza dello Stato e la successiva riattribuzione da parte delle stesse istituzioni locali delle prerogative avute a organi di governo statali e sovrastatali, in coerenza con le logiche dettate dalla globalizzazione.
Questa, sebbene in sintesi e con qualche semplificazione, la tesi di fondo del professor Muscarà, esposta in maniera invero un po’ confusa e arrovellata nel saggio edito nel novembre 2001, a pochi mesi dalla stringente vittoria elettorale della Casa delle Libertà.
Proprio da tale vittoria prende le mosse la trattazione: essa, ritiene il professore, è il segno di due importanti pulsioni popolari, ovvero la volontà di vedere applicate alla cosa pubblica le medesime logiche tipiche dell’impresa privata e l’esigenza dei singoli cittadini di sentire (e avere fisicamente) più vicine le istituzioni. Entrambe tali pulsioni hanno attraversato l’ultimo ventennio dello scorso secolo prendendo via via sostanza, radicandosi principalmente nel Nord del Paese, in un primo momento, e, successivamente, estendendosi all’intero stivale. Principali promotori e interpreti se ne sono fatti i movimenti localistici, fra cui è emersa la Lega di Bossi. Il localismo di tali movimenti, tuttavia, pare privo di un reale fondamento storico: niente lo lega con la domanda di regionalismo comparsa già nell’immediato dopoguerra e precisatasi vent’anni dopo nel regionalismo della sinistra e dei socialisti che portò a dar vita alle attuali Regioni, né tanto meno con la dottrina federalistica immessa nella logica democristiana da Don Sturzo. Piuttosto, “l’eredità bossiana è semmai socialista e potrebbe perfino essere avvicinata alle proteste che avevano alimentato sia Antonio Gramsci sia quanti – a sinistra – avevano accusato il processo unitario dello Stato di aver trascurato la gente”. In ogni caso, nel regionalismo che si origina negli anni ottanta e si sviluppa poi nel decennio successivo “predomina una volontà liberatrice dall’egemonia dei partiti, di cui si fanno portavoce tutte le forze, democratiche o istituzionali, che sentono urgere l’istanza di un radicale cambiamento dello Stato”. Il ruolo giocato dagli scandali di Tangentopoli nel produrre il carattere di urgenza di dette istanze è evidente e noto, come noto è anche il contemporaneo emergere dei movimenti leghisti del Nord, prima localizzati regionalmente e poi confluiti nella Lega Nord. L’anno chiave è quello che corre tra il 1993 e il 1994, in cui si dissolvono tutti i partiti tradizionali, nasce e si afferma il movimento di Berlusconi e la Lega prosegue nel suo consolidamento. Le cronache di quegli anni sono ancora fresche nella memoria e tutto sommato appare superfluo ripercorrerne le tappe: l’operazione di ricostruzione cui Muscarà dedica più di un capitolo appare sinceramente poco utile, se non al fine di dare un senso di compiutezza alla trattazione. Interessanti sono invece alcune osservazioni che egli cita dalla “Storia dell’Italia repubblicana” di Silvio Lanaro: “Il vero problema è il «non governo», la desolante incapacità del ceto politico di risolvere anche il problema più semplice. Certamente la causa è la partitocrazia, l’intreccio maligno fra interessi pubblici e privati, la trasformazione di imprese, banche, RAI-TV, ospedali, università, INPS, organi di stampa e quant’altro si vuole in accampamenti lottizzati dalle forze politiche; ma l’aspetto più perverso della partitocrazia, di cui raramente si tiene conto a sufficienza, non è l’immoralità, la protervia, la vocazione prevaricatrice in generale – vale a dire la disobbedienza alle comuni regole di onestà imposte dall’etica laica come da quella religiosa –, bensì un’attitudine a nuocere alla collettività derivante dalla paralisi, dalla «non scelta», dall’inazione, dal nullismo operativo che sono sempre provocati dall’infeudamento delle istituzioni all’interesse”. Se infatti in un primo momento è la protesta a prender piede, il passo è breve a che il movimento localista ricerchi il superamento dei suddetti problemi attraverso il tentativo di ricorso a forme di autogoverno. E’ qui che il Nord e la sua impresa – piccola e media ma anche grande al punto di essere spesso multinazionale e talora addirittura globale – assumono un ruolo di primissimo piano. L’accento leghista sulla secessione dell’Italia settentrionale dal resto del Paese e sulla dimensione etnico-culturale che tale secessione avrebbe dovuto giustificare appare in realtà non del tutto in linea con le istanze che spingono le imprese del Nord (e in particolare quelle del Nordest) a spalleggiare il movimento. Queste chiedono maggiore autonomia e una riforma sostanziale dello Stato, ma “le ragioni del dissenso da Roma, della protesta contro la politica meridionalistica, dell’insofferenza per la burocrazia e di tutte le altre lamentele e richieste non sono ritenute sufficienti a motivare una secessione dallo Stato italiano”. Le parole di Mario Carraro, ai tempi presidente dell’associazione degli imprenditori veneti, sono illuminanti: “Ogni imprenditore nordorientale, per quanto sia un acceso autonomista, sa bene una cosa: che noi siamo oggi dentro la quinta potenza industriale del mondo. Se andassimo da soli saremmo al massimo un bel Belgio. Anzi, molto peggio, perché ci mancherebbe tutto: storia, peso internazionale, diplomazia. Certe cose non si inventano dall’oggi al domani. Sarebbe una iattura.”.
Quasi commovente è a questo punto il ritratto che viene fatto del popolo veneto: “etica del lavoro, creatività, capacità sovrumana di faticare, andare dritto alle soluzioni, ecco le qualità degli abitanti di quest’area che ne hanno consentito lo sviluppo impensato”. Una vera e propria “idolatria del produttivismo”, insomma, che, unitamente al senso di frustrazione per sentirsi frenati nella corsa dal grosso carrozzone statale, produce quel collante speciale che trasforma il regionalismo in federalismo. “Le radici dell’identità veneta vengono da lontano, da quella civiltà contadina che è certamente tramontata ma ha lasciato segni profondi”, e se è vero che “molti dei tratti che abbiamo attribuito alla nostra regione potrebbero essere rinvenuti anche in altre”, si dimostra così che la ripartizione dello stivale in tre repubbliche federate da molti immaginata ha in sé meno significato dell’attuale ripartizione regionale: le Regioni ufficiali dello Stato, sebbene disegnate dalla Costituente senza un approfondito dibattito, presentano oggi ancora caratteri pregnanti di identità e radicamento culturale. Nasce qui, o, meglio, qui viene fatto nascere, quel paradosso di cui si è detto in principio: dall’esistenza di una quantità di localismi motivati da identità comunitarie definite viene il senso del federalismo, ma tali localismi – e il federalismo che ne consegue – non possono esimersi dal fare i conti con la rete globale degli scambi, oggi estesa a tutti gli ambiti dell’attività umana. L’interrogativo se sia la rete a fare i nodi o i nodi la rete viene sciolto senza eccessivi dubbi a favore della seconda ipotesi, dando così la quadratura al cerchio: il modello federale americano (anche qui!), che si propone quale “difesa del potere locale fondata sulla rinuncia funzionale a alcune sue condizioni al fine di non rinnegare ma di rafforzare la centralità democratica delle autonomie” (sic!) può ben applicarsi al caso italiano. “Insomma, per quanto paradossale possa sembrare, le Regioni stesse, una volta capovolta la logica che continua a considerarle articolazione dello stato centrale, diventate il mattone di partenza su cui reggere il nuovo stato, dovrebbero saper rinunciare a quella parte del potere locale che appare incompatibile con esso, esprimendo così la propria capacità di confrontarsi con la logica del potere attuale”. Già, paradossale…
Calogero Muscarà
Marsilio Editori, 2001
Cominciamo dalla fine: il paradosso federalista è il prodotto di due esigenze in sé contrapposte che dovranno però in qualche modo giungere a una conciliazione. Trattasi di una universale quanto evidente domanda di globalizzazione e di una un po’ più italiana ma altrettanto innegabile domanda di federalismo. Frutto di tale ineluttabile connubio sarà un paradosso che vedrà la devoluzione alle attuali istituzioni locali di una quantità di prerogative oggi di competenza dello Stato e la successiva riattribuzione da parte delle stesse istituzioni locali delle prerogative avute a organi di governo statali e sovrastatali, in coerenza con le logiche dettate dalla globalizzazione.
Questa, sebbene in sintesi e con qualche semplificazione, la tesi di fondo del professor Muscarà, esposta in maniera invero un po’ confusa e arrovellata nel saggio edito nel novembre 2001, a pochi mesi dalla stringente vittoria elettorale della Casa delle Libertà.
Proprio da tale vittoria prende le mosse la trattazione: essa, ritiene il professore, è il segno di due importanti pulsioni popolari, ovvero la volontà di vedere applicate alla cosa pubblica le medesime logiche tipiche dell’impresa privata e l’esigenza dei singoli cittadini di sentire (e avere fisicamente) più vicine le istituzioni. Entrambe tali pulsioni hanno attraversato l’ultimo ventennio dello scorso secolo prendendo via via sostanza, radicandosi principalmente nel Nord del Paese, in un primo momento, e, successivamente, estendendosi all’intero stivale. Principali promotori e interpreti se ne sono fatti i movimenti localistici, fra cui è emersa la Lega di Bossi. Il localismo di tali movimenti, tuttavia, pare privo di un reale fondamento storico: niente lo lega con la domanda di regionalismo comparsa già nell’immediato dopoguerra e precisatasi vent’anni dopo nel regionalismo della sinistra e dei socialisti che portò a dar vita alle attuali Regioni, né tanto meno con la dottrina federalistica immessa nella logica democristiana da Don Sturzo. Piuttosto, “l’eredità bossiana è semmai socialista e potrebbe perfino essere avvicinata alle proteste che avevano alimentato sia Antonio Gramsci sia quanti – a sinistra – avevano accusato il processo unitario dello Stato di aver trascurato la gente”. In ogni caso, nel regionalismo che si origina negli anni ottanta e si sviluppa poi nel decennio successivo “predomina una volontà liberatrice dall’egemonia dei partiti, di cui si fanno portavoce tutte le forze, democratiche o istituzionali, che sentono urgere l’istanza di un radicale cambiamento dello Stato”. Il ruolo giocato dagli scandali di Tangentopoli nel produrre il carattere di urgenza di dette istanze è evidente e noto, come noto è anche il contemporaneo emergere dei movimenti leghisti del Nord, prima localizzati regionalmente e poi confluiti nella Lega Nord. L’anno chiave è quello che corre tra il 1993 e il 1994, in cui si dissolvono tutti i partiti tradizionali, nasce e si afferma il movimento di Berlusconi e la Lega prosegue nel suo consolidamento. Le cronache di quegli anni sono ancora fresche nella memoria e tutto sommato appare superfluo ripercorrerne le tappe: l’operazione di ricostruzione cui Muscarà dedica più di un capitolo appare sinceramente poco utile, se non al fine di dare un senso di compiutezza alla trattazione. Interessanti sono invece alcune osservazioni che egli cita dalla “Storia dell’Italia repubblicana” di Silvio Lanaro: “Il vero problema è il «non governo», la desolante incapacità del ceto politico di risolvere anche il problema più semplice. Certamente la causa è la partitocrazia, l’intreccio maligno fra interessi pubblici e privati, la trasformazione di imprese, banche, RAI-TV, ospedali, università, INPS, organi di stampa e quant’altro si vuole in accampamenti lottizzati dalle forze politiche; ma l’aspetto più perverso della partitocrazia, di cui raramente si tiene conto a sufficienza, non è l’immoralità, la protervia, la vocazione prevaricatrice in generale – vale a dire la disobbedienza alle comuni regole di onestà imposte dall’etica laica come da quella religiosa –, bensì un’attitudine a nuocere alla collettività derivante dalla paralisi, dalla «non scelta», dall’inazione, dal nullismo operativo che sono sempre provocati dall’infeudamento delle istituzioni all’interesse”. Se infatti in un primo momento è la protesta a prender piede, il passo è breve a che il movimento localista ricerchi il superamento dei suddetti problemi attraverso il tentativo di ricorso a forme di autogoverno. E’ qui che il Nord e la sua impresa – piccola e media ma anche grande al punto di essere spesso multinazionale e talora addirittura globale – assumono un ruolo di primissimo piano. L’accento leghista sulla secessione dell’Italia settentrionale dal resto del Paese e sulla dimensione etnico-culturale che tale secessione avrebbe dovuto giustificare appare in realtà non del tutto in linea con le istanze che spingono le imprese del Nord (e in particolare quelle del Nordest) a spalleggiare il movimento. Queste chiedono maggiore autonomia e una riforma sostanziale dello Stato, ma “le ragioni del dissenso da Roma, della protesta contro la politica meridionalistica, dell’insofferenza per la burocrazia e di tutte le altre lamentele e richieste non sono ritenute sufficienti a motivare una secessione dallo Stato italiano”. Le parole di Mario Carraro, ai tempi presidente dell’associazione degli imprenditori veneti, sono illuminanti: “Ogni imprenditore nordorientale, per quanto sia un acceso autonomista, sa bene una cosa: che noi siamo oggi dentro la quinta potenza industriale del mondo. Se andassimo da soli saremmo al massimo un bel Belgio. Anzi, molto peggio, perché ci mancherebbe tutto: storia, peso internazionale, diplomazia. Certe cose non si inventano dall’oggi al domani. Sarebbe una iattura.”.
Quasi commovente è a questo punto il ritratto che viene fatto del popolo veneto: “etica del lavoro, creatività, capacità sovrumana di faticare, andare dritto alle soluzioni, ecco le qualità degli abitanti di quest’area che ne hanno consentito lo sviluppo impensato”. Una vera e propria “idolatria del produttivismo”, insomma, che, unitamente al senso di frustrazione per sentirsi frenati nella corsa dal grosso carrozzone statale, produce quel collante speciale che trasforma il regionalismo in federalismo. “Le radici dell’identità veneta vengono da lontano, da quella civiltà contadina che è certamente tramontata ma ha lasciato segni profondi”, e se è vero che “molti dei tratti che abbiamo attribuito alla nostra regione potrebbero essere rinvenuti anche in altre”, si dimostra così che la ripartizione dello stivale in tre repubbliche federate da molti immaginata ha in sé meno significato dell’attuale ripartizione regionale: le Regioni ufficiali dello Stato, sebbene disegnate dalla Costituente senza un approfondito dibattito, presentano oggi ancora caratteri pregnanti di identità e radicamento culturale. Nasce qui, o, meglio, qui viene fatto nascere, quel paradosso di cui si è detto in principio: dall’esistenza di una quantità di localismi motivati da identità comunitarie definite viene il senso del federalismo, ma tali localismi – e il federalismo che ne consegue – non possono esimersi dal fare i conti con la rete globale degli scambi, oggi estesa a tutti gli ambiti dell’attività umana. L’interrogativo se sia la rete a fare i nodi o i nodi la rete viene sciolto senza eccessivi dubbi a favore della seconda ipotesi, dando così la quadratura al cerchio: il modello federale americano (anche qui!), che si propone quale “difesa del potere locale fondata sulla rinuncia funzionale a alcune sue condizioni al fine di non rinnegare ma di rafforzare la centralità democratica delle autonomie” (sic!) può ben applicarsi al caso italiano. “Insomma, per quanto paradossale possa sembrare, le Regioni stesse, una volta capovolta la logica che continua a considerarle articolazione dello stato centrale, diventate il mattone di partenza su cui reggere il nuovo stato, dovrebbero saper rinunciare a quella parte del potere locale che appare incompatibile con esso, esprimendo così la propria capacità di confrontarsi con la logica del potere attuale”. Già, paradossale…
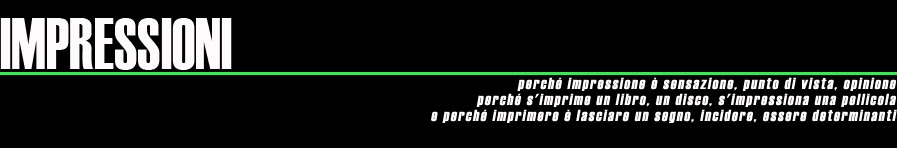.jpg)