Quantunquemente Antonio Albanese resti geniale nella costruzione di un personaggio surreale nelle intenzioni quanto persino iperrealista nei fatti, Cetto non ci convince: il film strappa le risate migliori quando riesce a mettere a nudo la follia di una certa politica che rinuncia in assoluta trasparenza a farsi portavoce di un qualsivoglia modello ideale per incarnare invece il peggio della società che rappresenta, ma non va oltre.
Cetto è il non plus ultra del politically uncorrect, ed è genuinamente onesto nell’esserlo: proprio come quella politica di cui è caricatura, ciecamente convinto di essere nel giusto, mette da parte ogni remora di ordine etico o morale per far passare l’idea tutta nuova che corruzione, malaffare, latrocinio e interesse privato possono trovare la loro giustificazione nella pratica comune e nel consenso altrui, poco importa come lo si sia ottenuto. Sulla scia del “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, corrompere il prossimo diventa lo strumento migliore per essere l’eletto fra i corrotti, e avere avversari corrotti la giustificazione migliore per essere più corrotti di loro, fino a proclamare definitivamente che la corruzione è cosa buona e giusta e che chi non la pratica in pubblico senz’altro la pratica in privato, di nascosto, ed è dunque peggiore egli stesso di quanto non dica degli altri.
Memorabili sono i suo slogan: “Prima voti, poi rifletti”, “I have no dream, ma mi piace u pilu!”. Memorabili i suoi comizi (“Mi hanno chiesto cosa voglio fare per i poveri e i bisognosi: una benemerita minchia!”) e le sue lezioni di educazione sentimentale al figlio Melo, costretto a lasciare la fidanzata perché di misure assai poco generose. Ma tutto questo l’avevamo già visto a Zelig!
Dove il film manca completamente è sull’altro fronte, quello del mondo intorno a Cetto: come è possibile che un simile personaggio faccia proseliti e vinca le elezioni? Qual è la radice del successo di questa classe politica che incarna il peggio della Nazione che rappresenta erigendolo a sistema? Non basta aggrapparsi al broglio in cabina, al parentame e al clientelismo: fosse solo questo non ci sarebbe bisogno di un film, è roba vecchia. C’è di più, là fuori: c’è un mondo che vede sovvertiti giorno dopo giorno i principi stessi su cui si è costituita la civiltà moderna, in un contesto di pressoché generale noncuranza. E nessuno che sappia spiegarselo! Avrebbe potuto farlo lui, Cetto: spiegarci com’è che certi meccanismi fanno breccia nel cuore di un comune cittadino e farci così sentire il peso, uscendo dalla sala, di essere stati anche noi una volta nella vita fra gli elettori di un Laqualunque qualsiasi. Avrebbe potuto, ma forse avrebbe dovuto avere accanto qualcuno, mentre attorno a lui c’è il nulla.
In un solo momento la regia di Giulio Manfredonia, latitante per il 90% del film, notaio per la restante parte, si accorge che questo è il tema: quando al termine di un dibattito televisivo condotto con le armi di una faziosità iperbolica quanto già troppe volte vista dal vivo, la telecamera stringe sul volto affranto dell’avversario di Cetto, mentre le luci dello studio si spengono lentamente e tutti escono festanti.
Per il resto è tutto vuoto: i personaggi spudoratamente macchiettistici che circondano il nostro eroe, a mezza via tra Franco e Ciccio e la caricatura di Marlon Brando, la moglie starnazzante, incapace di essere anche solo la parodia di quel che dovrebbe essere, fino al guru barese che parla milanese (ma perché, dico io?), interpretato da uno spaesatissimo Rubini, inspiegabilmente costretto ad essere quello che non è, palesemente in imbarazzo in panni non suoi.
Insomma... una grande occasione sprecata.
E un gran peccato, perché Cetto funziona davvero bene, ma non riesce ad andare oltre il format modello “Zelig” (v. anche il recente strasuccesso di Checco Zalone, tanto visto quanto mal fatto), il che costringe ad amare riflessioni nostalgiche dei tempi che furono, quando Totò gridava “Vota Antonio, vota Antonio” e Alberto Sordi girava “Tutti dentro!” con una parrucca da fare impallidire quella di Cetto.
Ma noi vogliamo bene al cinema italiano, nonostante tutto, perciò faremo il tifo per Albanese a Berlino. E siamo sicuri che i tedeschi sapranno apprezzare meglio di noi quest’Italietta tutta spaghetti e mafia di paese di cui noi abbiam piene le tasche. E pure i coglioni.
Cetto è il non plus ultra del politically uncorrect, ed è genuinamente onesto nell’esserlo: proprio come quella politica di cui è caricatura, ciecamente convinto di essere nel giusto, mette da parte ogni remora di ordine etico o morale per far passare l’idea tutta nuova che corruzione, malaffare, latrocinio e interesse privato possono trovare la loro giustificazione nella pratica comune e nel consenso altrui, poco importa come lo si sia ottenuto. Sulla scia del “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, corrompere il prossimo diventa lo strumento migliore per essere l’eletto fra i corrotti, e avere avversari corrotti la giustificazione migliore per essere più corrotti di loro, fino a proclamare definitivamente che la corruzione è cosa buona e giusta e che chi non la pratica in pubblico senz’altro la pratica in privato, di nascosto, ed è dunque peggiore egli stesso di quanto non dica degli altri.
Memorabili sono i suo slogan: “Prima voti, poi rifletti”, “I have no dream, ma mi piace u pilu!”. Memorabili i suoi comizi (“Mi hanno chiesto cosa voglio fare per i poveri e i bisognosi: una benemerita minchia!”) e le sue lezioni di educazione sentimentale al figlio Melo, costretto a lasciare la fidanzata perché di misure assai poco generose. Ma tutto questo l’avevamo già visto a Zelig!
Dove il film manca completamente è sull’altro fronte, quello del mondo intorno a Cetto: come è possibile che un simile personaggio faccia proseliti e vinca le elezioni? Qual è la radice del successo di questa classe politica che incarna il peggio della Nazione che rappresenta erigendolo a sistema? Non basta aggrapparsi al broglio in cabina, al parentame e al clientelismo: fosse solo questo non ci sarebbe bisogno di un film, è roba vecchia. C’è di più, là fuori: c’è un mondo che vede sovvertiti giorno dopo giorno i principi stessi su cui si è costituita la civiltà moderna, in un contesto di pressoché generale noncuranza. E nessuno che sappia spiegarselo! Avrebbe potuto farlo lui, Cetto: spiegarci com’è che certi meccanismi fanno breccia nel cuore di un comune cittadino e farci così sentire il peso, uscendo dalla sala, di essere stati anche noi una volta nella vita fra gli elettori di un Laqualunque qualsiasi. Avrebbe potuto, ma forse avrebbe dovuto avere accanto qualcuno, mentre attorno a lui c’è il nulla.
In un solo momento la regia di Giulio Manfredonia, latitante per il 90% del film, notaio per la restante parte, si accorge che questo è il tema: quando al termine di un dibattito televisivo condotto con le armi di una faziosità iperbolica quanto già troppe volte vista dal vivo, la telecamera stringe sul volto affranto dell’avversario di Cetto, mentre le luci dello studio si spengono lentamente e tutti escono festanti.
Per il resto è tutto vuoto: i personaggi spudoratamente macchiettistici che circondano il nostro eroe, a mezza via tra Franco e Ciccio e la caricatura di Marlon Brando, la moglie starnazzante, incapace di essere anche solo la parodia di quel che dovrebbe essere, fino al guru barese che parla milanese (ma perché, dico io?), interpretato da uno spaesatissimo Rubini, inspiegabilmente costretto ad essere quello che non è, palesemente in imbarazzo in panni non suoi.
Insomma... una grande occasione sprecata.
E un gran peccato, perché Cetto funziona davvero bene, ma non riesce ad andare oltre il format modello “Zelig” (v. anche il recente strasuccesso di Checco Zalone, tanto visto quanto mal fatto), il che costringe ad amare riflessioni nostalgiche dei tempi che furono, quando Totò gridava “Vota Antonio, vota Antonio” e Alberto Sordi girava “Tutti dentro!” con una parrucca da fare impallidire quella di Cetto.
Ma noi vogliamo bene al cinema italiano, nonostante tutto, perciò faremo il tifo per Albanese a Berlino. E siamo sicuri che i tedeschi sapranno apprezzare meglio di noi quest’Italietta tutta spaghetti e mafia di paese di cui noi abbiam piene le tasche. E pure i coglioni.
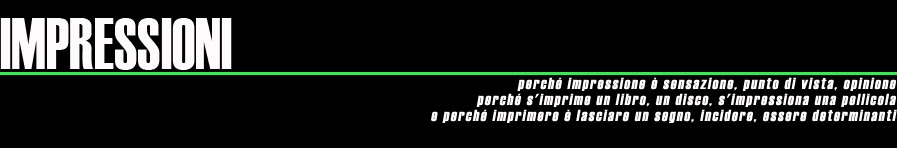.jpg)
